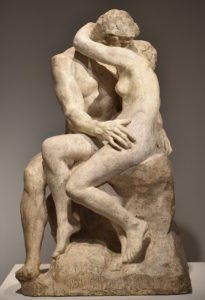Una cosa che capita spesso durante le visite al museo è che nel momento in cui si arriva di fronte alla noce che rappresenta una moltitudine di diavoletti rossi impegnati nella tortura di alcuni peccatori, i visitatori fanno un ghigno e dicono frasi del genere “non c’è abbastanza spazio all’inferno per rappresentarli tutti”. Ma di chi stiamo parlando? Questa mia riflessione nasce soprattutto da questa caratteristica della collezione delle miniature della Divina Commedia di Dante Alighieri creata da don Antonio Maria Esposito, custodita nel Museodivino in cui da qualche mese sto collaborando. Il nostro artista ha voluto rappresentare nella porzione di noci dedicate all’inferno la maggior parte dei peccatori che hanno una cosa in comune: hanno tutti arrecato danno alla comunità: bugiardi, lussuriosi, ladri e soprattutto barattieri, coloro che creano così tanto stupore tra i visitatori.

Potere e Corruzione: come ieri così oggi
Ci troviamo all’inizio del XXI canto dell’inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri quando vengono presentate le figure di questi peculiari peccatori all’interno dell’opera: i barattieri, cioè coloro che in vita hanno ricoperto cariche pubbliche o istituzionali, ma invece di perseguire l’interesse collettivo, hanno privilegiato vantaggi personali, spesso economici, abusando del loro potere arrecando danno ad altri. In ambito contemporaneo, tali figure vengono spesso assimilate a quelle dei politici corrotti. Notevole è il modo attraverso cui Dante descrive questi peccatori e il luogo in cui li colloca. Essi si trovano nella quinta bolgia dell’VIII cerchio dell’Inferno, in essa venivano immersi in pece bollente e tormentati da diavoli che li trafiggevano con uncini affilati. La loro brama di potere e denaro ha avvelenato la loro coscienza, rendendoli incapaci di redenzione. Immersi nella pece nera, riflettono l’oscurità morale che li consuma, simboli viventi della giustizia tradita e dell’anima corrotta.

Quando non puoi sconfiggerli, unisiciti a loro: ma dante era forse un barattiere?
Quello che mi colpisce è che Dante non fa nessuno sconto a questi peccatori, e questo mi porta a riflettere anche sulla sua stessa esperienza di uomo esiliato e accusato: mi sembra quasi che stia parlando non solo di loro, ma anche a sé stesso e, in fondo, anche a me. Proprio rispetto a questo, mi sembra opportuno mostrare un estratto di un articolo di Salsano Fernando intitolato “Dante e la baratteria:
“Mi pare infine accettabile l’ipotesi della radice autobiografica dell’impegno che il poeta spende nel far rivivere prodezze e miserie della baratteria. Ma credo si possa parlare di un rapporto autobiografico solo precisando che, se è vero che Dante non poteva dimenticare che il suo doloroso esilio era stato comminato proprio con l’accusa di baratteria, mancano poi elementi validi per sostenere che nella bolgia dei barattieri si riscontri una risposta diretta a quell’accusa e a quel dolore. Accusa, poi, che per essere formula convenzionale cui il gioco delle parti ricorreva per saziare chi vinceva e per esautorare chi era vinto, perdeva o non aveva mai avuto forza infamante, se non quella di segnare sulle spalle del vinto il marchio della sconfitta. Piuttosto, in un animo agguerrito per intelletto e fede come quello di Dante, la sigla della baratteria poteva risultare la spia d’un costume, il segnale d’un decadimento infirmante ogni aspetto della vita cittadina.”

L’esempio lampante: un barattiere tipo
Tra i personaggi che Dante presenta in questo canto, tra la schiera dei barattieri lucchesi (città nota per essere ricca di queste figure secondo l’autore), spicca la figura di Bonturo Dati, un politico fiorentino della fazione dei guelfi bianchi che era per Dante uno dei più noti esponenti del malgoverno della città di Firenze in quegli anni. Infatti, proprio costui era noto per la sua violenza politica e per l’uso del potere a scopi personali e clientelari. Vi è dedicata proprio una terzina a questo personaggio che cita:
“a quella terra, che n’è ben fornita,
ogn’uomo v’è barattier, fuor che Bonturo;
del no, per li denar, vi si fa ita”

Una riflessione interiore: cosa lego alle emozioni che dante genera in me
Da qui è nata una mia profonda riflessione, con sguardo sulla società contemporanea, rispetto al potere che il denaro e la corruzione hanno nell’agire politico all’interno delle istituzioni a discapito degli interessi popolari, ma anche dei valori che muovono, nel migliore dei casi, le figure che ricoprono ruoli di rappresentanza.
Interessi, secondi fini e attualità: chi sono i barattieri di oggi
Un evento che in queste settimane mi ha fatto molto riflettere e che non ho potuto non legare a questa forma di denuncia di Don Antonio è quello dello scandalo urbanistico che ha interessato la città di Milano nelle ultime settimane, il quale ha visto molti politici della giunta comunale, nonché molte figure dell’imprenditoria edilizia, essere protagoniste di un modello di gestione e concessione dei permessi urbanistici (il cosiddetto modello Milano) le cui radici affondano nella più totale irregolarità, secondo le prime ricostruzionsci. I fatti: una maxi-inchiesta con decine di indagati, tra cui il sindaco Sala, l’assessore Tancredi, l’architetto Marinoni e il costruttore Catella. Quando ho letto di questa vicenda ho provato un senso di rabbia e impotenza: mi è sembrato di vedere con chiarezza come i politici e gli imprenditori coinvolti abbiano agito esattamente come i barattieri di Dante, pensando solo al proprio tornaconto e tradendo la fiducia della comunità. Il modello, prima autorevole esempio di rigenerazione urbana, è ora percepito come corrotto e ha provocato un crollo di fiducia bipartisan. L’inchiesta urbanistica sta facendo emergere un modello di città che le forze politiche, sociali, sindacali e di movimento più coerenti, non imbrigliate nelle maglie dei poteri locali, denunciano da tempo: Milano è diventata, a pieno titolo, un parco giochi per ricchi, al servizio di privati e speculatori. Un sistema di “governo continuo” che travalica le correnti interne e i partiti stessi – siano essi di centrosinistra o centrodestra – e che ha fatto da trampolino alla cosiddetta “rigenerazione” di Milano. Ma per capire di che tipo di crescita stiamo parlando, basta osservare chi ci ha guadagnato e chi, invece, ne ha pagato le conseguenze sulla propria pelle. Mentre il percorso giudiziario prosegue, i dati parlano chiaro: Milano è la città dove le disuguaglianze crescono più che in ogni altra parte d’Italia, dove il diritto alla casa è un lusso, i servizi sono una giungla di appalti e privatizzazioni, il centro storico è ormai una vetrina per turisti oltre che il quartier generale degli squali della speculazione.

Socialità alternativa come anticorpo a questa corruzione dilagante
Recente è la notizia dello sgombero di uno dei centri sociali più importanti di Italia, il “Leoncavallo”, il quale vanta una storia politica di comunità, attività sociali e sorgente di controcultura di più di 50 anni. Pienamente in linea con il ragionamento precedentemente affrontato si colloca questo evento, lo dimostra la volata in borsa che la società appartenente al proprietario dello spazio occupato ha avuto nello stesso giorno dello sgombero, circa un +4%, a conferma della ricerca devastatrice di spazi da destinare al processo di speculazione della città a scapito persino di luoghi che rappresentano per la comunità del territorio un elemento di benessere, di crescita e di cuscinetto sociale. Ed è proprio qui che nasce il collegamento e l’attualizzazione del pensiero dantesco. Come nell’inferno dantesco c’è un’accusa ai barattieri, come negli anni 60 Don Antonio denuncia chi fa danno alla comunità, oggi non posso che pensare che la condanna a questi soggetti è ancora del tutto attuale, e come me immagino tanti quotidianamente riflettano sulla rassegnazione a questo sistema corrotto in cui siamo nati.

Non solo milano, il sistema e’ lo stesso in ogni luogo
Ma Milano non è l’unico esempio da poter fare, infatti nelle stesse settimane è acaduta un’altra vicenda, che forse mi ha toccato ancora più da vicino ed è stata nei miei pensieri per giorni e giorni, nella città di Napoli. Attenzione, non sono qui per analizzare il fenomeno dell’overtourism e della speculazione edilizia città per città, anzi voglio concentrarci su un altro aspetto della gestione e della governabilità di un territorio L’incendio al Vesuvio mi ha toccato nel profondo: ricordando quello del 2017, ho sentito come se la stessa ferita si fosse riaperta. Mi sono chiesto con rabbia: ma chi doveva proteggere questo bene comune, dov’era? Non è anche questa una forma di tradimento verso la comunità? A quel punto mi sono chiesto: cosa direbbe Dante non solo dei corrotti, ma anche di chi, pur senza rubare direttamente, tradisce la fiducia pubblica per negligenza e incuria? È una domanda che mi porto dietro da quando ho letto della devastazione del Parco del Vesuvio. Questo è il caso di una classe dirigente che non è stata in grado di prevenire un evento già capitato anni prima e di entità enorme.

Chi controlla il controllore?: il concetto di responsabilita’ politica
Fin dove si possono considerare le responsabilità collettive, i danni imprevedibili e le volontà benevole e fin dove invece c’è da considerare una componente di malafede e corruzione morale o economica che sia di tali soggetti? Si lascia qui al lettore la possibilità di trarre le possibili risposte. Qui è invece il caso di citare Maria Grazia Melchionni in un suo articolo chiamato “Convivenza civile e responsabilità politica in Dante”:
<<Come nella concezione etica posta a fondamento del Convivio e della Commedia, anche nella visione politica, esplicitata nella Monarchia, Dante introduce il principio di responsabilità come elemento specifico che deve caratterizzare il comportamento di governati e governanti. Principio che a sua volta riposa su un altro caposaldo assai caro al poeta: quello del libero arbitrio da lui definito il più gran dono conferito da Dio alla natura umana, perché per esso raggiungiamo qui la nostra felicità come uomini>>

Un’alternativa e’ possibile?
A questo punto viene da chiedersi perché tali forme di gestione pubblica, di governo e di corruzione fanno così tanto storcere il naso a chi le vive indirettamente. A mio avviso, la risposta è che la società a cui dovremmo mirare è diversa da quella attuale. In essa, la responsabilità non sarebbe più vista solo come un fatto individuale, ma come un elemento collettivo. Ciò non significa permettere una pericolosa deresponsabilizzazione, ma riconoscere che ogni azione individuale incide, in positivo o in negativo, sull’interesse della comunità. Se i funzionari milanesi avessero mantenuto salda la loro posizione imperturbabile di amministratori per il bene del popolo forse molti problemi come la crisi abitativa studentesca, le cappe di calore nei centri urbani, la costruzione massiva in aree definite zone rosse per la densità abitativa, oggi non avrebbero lo stesso peso che hanno. Se i dirigenti del parco nazionale del Vesuvio avessero svolto correttamente le politiche di prevenzione necessarie, forse la devastazione totale della fauna e della flora, senza contare le abitazioni e le strutture pubbliche (strade, staccionate, etc.), oggi non sarebbe riaccaduta dopo i fatti del 2017. Il discorso si centra sempre sullo stesso punto chiave: chi subisce maggiormente le conseguenze di queste inadempienze o di comportamenti discutibili da parte della classe dirigente? Quello che io sento, parlando anche con i miei coetanei, è soprattutto sfiducia. Una sfiducia che spesso diventa rassegnazione e apatia, come se non avessimo più gli strumenti per reagire a questo sistema. Quando chi governa tradisce il proprio mandato, a pagare il prezzo sono sempre i cittadini comuni, spesso privi degli strumenti per reagire. È qui che diventa urgente recuperare un’etica pubblica condivisa, capace di superare interessi personali e logiche di potere. Solo attraverso una partecipazione attiva e consapevole si può sperare di invertire una rotta che appare ormai pericolosamente consolidata.
Restare non conviene, sfortunatamente….
Questa sfiducia emerge anche e soprattutto, mio modesto parere, nei comportamenti demografici e migratori delle nuove generazioni. Sempre più conosciuto è il fenomeno italiano dei cosiddetti “cervelli in fuga”, che per mancate opportunità di studio o lavorative sono costretti ad emigrare all’estero dove si trasferiscono stabilmente. Molte volte, tuttavia, anche il rapporto che intercorre tra i giovani e le istituzioni (sempre di più simbolo di inefficienza e corruzione) contribuisce considerevolmente alla scelta dei giovani di non far ritorno nel paese anche un domani quando le condizioni saranno più favorevoli. Una disfatta su tutti i fronti, per i giovani che contro la propria volontà devono affrontare scelte così difficili, ma anche per le istituzioni e per l’Italia tutta che perde così buona parte della fetta più importante della società, i giovani, il futuro.

Ma quindi, che fare?
In conclusione di quest’articolo vorrei riportare un altro estratto del paper di Maria Grazia Melchionni:
<< E fu così che quando, dopo quasi quindici anni di esilio, gli fu offerto di rientrare a Firenze a condizioni che egli giudicò ignominiose, oppose un secco rifiuto con argomentazioni in cui non solo faceva valere con forza la sua innocenza, ma si proclamava di fatto “cittadino del mondo” che, pur privato di tutto, può sempre e comunque abbandonarsi sotto qualsiasi cielo alla contemplazione delle bellezze dell’universo ed alla meditazione delle “dolcissime verità” scientifiche, filosofiche, teologiche.>>
Questo breve articolo vuole essere una riflessione personale, ma anche un invito, una mano tesa al confronto e alla condivisione di pareri ed esperienze. Chissà se forse il problema di tutta questa storia non sia propria l’individualità che spinge all’isolamento, e che quindi l’antidoto non sia la socialità che spinge all’aggregazione solidale. Forse il vero inferno non è fatto di fuoco e pece, ma dell’indifferenza che ci divide: solo scegliendo la socialità come antidoto alla corruzione possiamo riscrivere, insieme, una nuova Commedia.

Bibliografia
- Contropiano – Crolla il modello Milano: un sistema corrotto di speculazione che solo qualcuno denunciava – 18 luglio 2025.
- Il Manifesto – Modello Milano sotto inchiesta – luglio 2025.
- Salsano, Fernando. “Dante e la baratteria.” Pane quotidiano: elzevìri.-(L’interprete; 93) (2007)
- https://www.jstor.org/stable/10.2307/27094439
- https://www.renewablematter.eu/incendio-vesuvio-danni-economici-ambientali-task-force-cause?